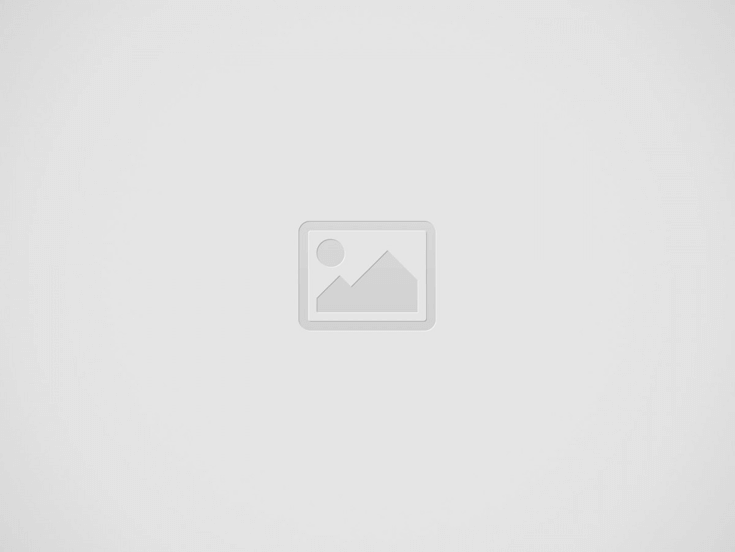

La citazione di Marta, autrice del libro è lo specchio di una parte di un sistema giudiziario che anche l’Europa ci chiede di riformare: non credo che il pannicello caldo della riforma Cartabia, approvata dal Parlamento il 16.6.2022, o la bocciatura dei quattro referendum sulla giustizia abbiano risolto gli annosi e drammatici problemi che caratterizzano il ruolo dei giudici, il modo di avviare le indagini, istruire i processi e portarli a sentenza. Non mi addentrerò in questo campo perché non ne ho le competenze e, ove ce ne fosse bisogno, voglio precisare che questo non è un giudizio critico su tutta la magistratura italiana e sul suo operato, ma su un sistema che ha nel giudice “l’arbitro in terra del bene e del male” (F. De Andrè) con enormi poteri, primo fra tutti quello di porre sotto sequestro i patrimoni privati, anche sulla base di sospetti, senza bisogno di procedimenti penali. Questa arbitrarietà lo pone in taluni casi al di sopra della legge stessa, che egli rappresenta, grazie alla sua non punibilità nell’esercizio del suo lavoro.
Il caso Impastato
Sono entrato in un’aula giudiziaria nel 2000, citato come teste nel processo per Peppino Impastato. Un iter iniziato nel 1978, quando il mio amico venne fatto saltare in aria con un carico di tritolo sui binari e l’omicidio venne depistato come attentato terroristico o suicidio. Ventiquattro anni di inchieste, controinchieste, chiusura e riapertura delle indagini, sino al processo, durato oltre sei anni e conclusosi con la condanna dei mandanti del delitto. In mezzo, un gruppo di compagni, decisi a volere giustizia e una donna eccezionale, Felicia, la madre di Peppino ostinata nella sua intransigente voglia di vedere alla sbarra gli assassini di suo figlio. Alla fine abbiamo vinto, ma con l’amaro in bocca, davanti alla considerazione che, per avere giustizia non si può aspettare 22 anni. Un tempo trascurabile, davanti ai morti di Portella della Ginestra, che aspettano dal 1947, con alcuni degli atti che li riguardano, ancora secretati.
Processo alla satira
Mi sono ritrovato alla tarda età di 72 anni, come imputato, all’interno di un’aula giudiziaria, per essermi permesso di satireggiare su un giudice presidente di sezione, su un procuratore capo, su un colonnello della DIA e su alcuni amministratori giudiziari, legati da vincoli di collaborazione: un semplice articolo risolvibile in una risata, si è trasformato in un atto di diffamazione nei confronti del procuratore-capo, con la richiesta, nei miei confronti, di una condanna a un anno e mezzo di carcere e una penale di molte migliaia di euro. In quel momento mi sono sentito come un criminale, in un tribunale d’inquisizione, dopo una vita passata a difendere la legalità e a promuoverla. “Chi tocca i fili muore”. Alla fine sono stato condannato a pagare 500 euro di multa, anche in appello, ed ho fatto allora la prima riflessione sul fatto che non esistono sentenze giuste, ma solo sentenze, che la giustizia non è un nobile concetto immortale, al di là delle debolezze umane, ma l’applicazione e l’espressione di decisioni prese da uomini sulla colpevolezza o innocenza di un imputato, ricavata sulla base di personali convinzioni, di pressioni amichevoli e politiche, di pregiudizi, di volontà di arrivismo, di arringhe affidate all’autorevolezza e all’eloquenza dell’avvocato e del pm e altre infinite concause.
Il pre-giudizio
Quando il giudice avvia il procedimento, su segnalazione, denunce, indagini degli organi inquirenti, ha già percorso un buon tratto della strada che porta alla decisione finale. Per spuntarla non si esclude il ricorso a qualsiasi espediente, dall’occultamento di reperti e documenti che hanno un peso risolutorio, al passaggio alla stampa di atti del procedimento coperti dal segreto istruttorio, ma che servono ad avviare la criminalizzazione dell’inquisito e quindi a tracciare con evidenza la strada della sua colpevolezza ante litteram, della quale la condanna è l’atto finale. Si fa presto a dire che una persona non può essere giudicata colpevole sino al momento della sentenza definitiva: il giornalismo italiano decide della sua colpevolezza al momento dell’apertura delle indagini e, in caso di assoluzione, cinque, sei, dieci anni dopo, tutti hanno ormai rimosso il caso di colui che hanno pre-giudicato.
Il patteggiamento
Nella mia attività giornalistica mi sono imbattuto in drammi umani, storie di persecuzioni e accanimenti giudiziari, di maltrattamenti carcerari, di ricatti fatti dai giudici, come quello, citato nel libro, di Nicola Sarcinella: “Patteggia e vedrai tuo figlio”, un bambino appena nato. E il patteggiamento è un’ammissione di colpa che gratifica e rende credibile l’operato del giudice che ha avviato l’indagine, di quello che ha rinviato a giudizio e di quello che si è occupato del successivo procedimento: scegliere la via del processo è un rischio che si può evitare con una semplice dichiarazione che confermi che lo stato non ha speso i suoi soldi inutilmente. Per contro il dramma si allunga, si amplifica, erode giornalmente la sensibilità e la coscienza di chi sa di non aver commesso alcun reato e di essere vittima di strategie e meccanismi di cui egli è solo un minuscolo frammento, sulla cui pelle è possibile giocare. “Durante la mia ingiusta detenzione faccio uno sciopero della fame, penso al suicidio, subisco un’aggressione sessuale. Non avrei mai resistito senza la mia fede in Dio. E senza la voglia di tornare da mio figlio”. (pag. 77).
La perdita della stima di chi ti circonda, spesso anche degli affetti più cari, oltre che la credibilità, il posto di lavoro, i propri beni posti sotto sequestro, sono gli aspetti più dolorosi, legati alla condizione interiore di chi si trova nell’occhio del ciclone e spesso non riesce a sopportare il meccanismo che già in partenza lo individua come responsabile e colpevole, e l’angoscia può anche portare al suicidio, come nel caso del Rettore dell’Università di Parma Loris Borghi, (14 marzo 2018) subito archiviato e presentato come un’ammissione di colpa.
Il caso di Pino Maniaci
Il direttore della emittente in cui presto la mia collaborazione, Pino Maniaci, alle tre di notte si vide presentare alla sua casa tre alti ufficiali che gli notificarono il divieto di risiedere in provincia di Palermo e di Trapani, divieto revocato dopo pochi giorni, per un vizio di forma, reiterato, revocato di nuovo, con l’accusa di estorsione e la diffusione nazionale di un video che, ritagliando frammenti d’intercettazione, attraverso riprese preconfezionate dalle stesse forze dell’ordine, presentava come estorsione alcune richieste di qualche contributo di assistenza per una bambina disabile, in un contesto in cui l’imputato era presentato come un pervertito e uno che usava la sua emittente per ricattare i politici locali. Anche qua cinque anni di udienze, rinvii, testimonianze prima firmate, durante gli interrogatori, poi revocate, per arrivare all’assoluzione. Ma anche qua chi aveva istruito il caso non poteva ammettere di essersi sbagliati, per cui sono state emesse alcune sentenze di condanna per diffamazione a mezzo stampa che nulla c’entravano con l’inchiesta, ma che erano state messe dentro come punto di giustificazione di tutto l’impianto processuale. Maniaci ha subito commentato: “Quando ti buttano addosso un secchio di merda, la puzza non se ne va più”. E in realtà quella puzza è rimasta. (vedi il mio libro “In nome dell’antimafia”).
Il caso di Marta
Gli avvenimenti in cui si trova coinvolta Marta si muovono su un binario che da un lato affronta e descrive la sua odissea giudiziaria, dall’altro il percorso difficile e praticamente fermato o quantomeno rallentato, bloccato, dopo questa inchiesta, di inserire, nella medicina ospedaliera italiana la terapia del dolore tra i settori ai quali è indispensabile ricorrere per le condizioni e le patologie di un paziente, che non è solo quello terminale o oncologico. Marta aveva cominciato ad occuparsi della terapia del dolore anche all’interno delle carceri, quando è stata bloccata nel suo progetto.
Tutto comincia con la data d’inizio del libro, l’8 maggio 2017, allorchè un esercito di 200 carabinieri di tutte le regioni del Nord Italia, si mobilita per una operazione definita Pasimafi, con l’arresto di 19 medici e operatori del settore, oltre che con il sequestro di due società e di 470 mila euro. L’accusa è quella di corruzione ed è condotta dai NAS di Parma e dalla locale Procura. 52 perquisizioni, 75 indagati, in capo a tutti un luminare della terapia del dolore, oltre che un estensore della legge 15 marzo 2010 n. 38, il prof. Fanelli: per semplificare il tutto, sembra che l’accusa sia quella di agevolare alcune ditte nella prescrizione dei farmaci, in cambio di illeciti profitti e incarichi. Prima curiosità: Marta saprà solo dopo sette mesi, cioè, ci tiene a precisare, duecentotrentuno giorni, di essere nell’elenco degli indagati, fatto circolare intanto in tutta la stampa locale e nazionale.
Pubblicato su antimafiaduemila.com
Caro Peppino, ti hanno fatto una statua a Ponsacco, scolpita da David Broggi, ti hanno dedicato alberi, strade e targhe in circa…
Antonio Gramsci scrisse che la Storia si ripete sempre e la seconda è una farsa.…
È passato poco più di un mese dal ritrovamento di Andrea Prospero, giovanissimo studente universitario di Lanciano,…
Sono passati oltre cinque mesi dall’archiviazione come “suicidio” della morte di Jois Pedone disposta dalla Gup del…
«A chi dà fastidio la memoria di Jois Pedone? Chi vuole cercare di intimidire la…
«Il caso di Vasto. Jois Pedone ucciso dalla luna?» è il titolo della puntata di…