L’avvocato Fabio Repici e il giornalista Alfio Caruso hanno presentato alla Procura Generale di Roma la richiesta di revisione del processo intentato nel 1966 dagli onorevoli Bernardo Mattarella e Calogero Volpe contro Danilo Dolci e Franco Alasia. Si tratta di un passaggio importante e necessario dopo trent’anni di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e in ultimo quelle reiterate da Francesco Di Carlo (definito nella sentenza di condanna degli assassini di Mauro Rostagno «del tutto credibile»). Dopo averlo già affermato nel 1996, senza che la famiglia Mattarella battesse ciglio, Di Carlo la scorsa primavera ha ribadito e spiegato l’affiliazione mafiosa sia di Mattarella sia di Volpe. Sembra quindi giunto, con il consenso della famiglia di Danilo Dolci, il momento di cancellare l’ignominia di un’ingiusta condanna ai danni della prima, vera icona della lotta a Cosa Nostra e del suo principale collaboratore. Anche per dimostrare che quest’Italia non consente più alla mafia di portare alla sbarra l’antimafia.
Alfio Caruso è stato denunciato dai parenti di Bernardo Mattarella, compreso l’attuale presidente della Repubblica Sergio, per avere nel suo libro “Da cosa nasce cosa”, parlato dei rapporti e delle amicizie tra il pluriministro democristiano e le famiglie mafiose del suo paese. La cosa, che era passata sotto silenzio nelle prime edizioni del libro, è esplosa dopo la nomina di Sergio Mattarella.
Nella richiesta preparata da Alfio Caruso e dall’avvocato Repici si legge:
“Le recenti ammissioni di Francesco Di Carlo sull’affiliazione mafiosa degli onorevoli Bernardo Mattarella e Calogero Volpe proiettano inquietanti domande su un famoso caso giudiziario di metà anni Sessanta: il processo intentato proprio dal duo Mattarella-Volpe contro il sociologo Danilo Dolci. Prima icona dell’antimafia dentro un periodo storico, nel quale per vent’anni il sostantivo «mafia» era stato escluso dal vocabolario ufficiale della Repubblica, Dolci fu promotore di iniziative sociali e d’inchieste pubbliche, che ebbero il merito di scoprire, in anticipo su magistrati, poliziotti, giornalisti, i patti inconfessabili fra politici e boss, la contaminazione di larga parte della società siciliana. Tra quelli colpiti dagli strali acuminati di Dolci i due parlamentari democristiani, che dal 1948 facevano incetta di voti e d’incarichi e del cui spessore mafioso Di Carlo aveva già parlato al tempo delle sue prime dichiarazioni nel 1996.
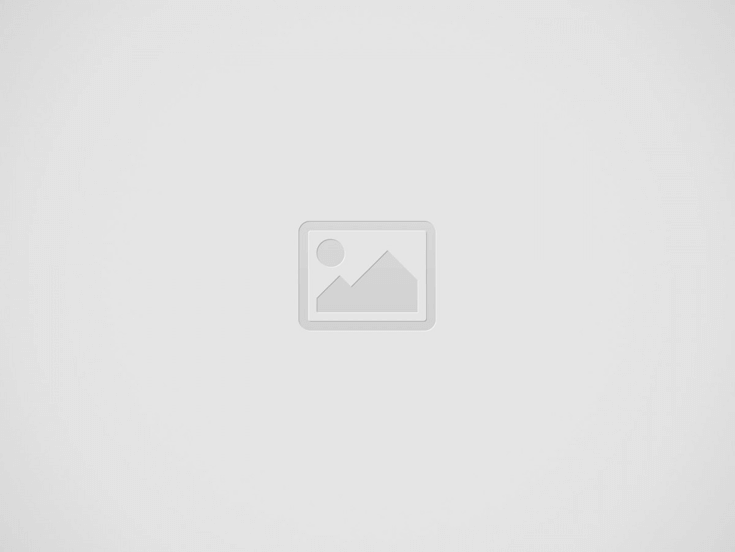

Eppure nel 1966 Mattarella e Volpe querelarono per diffamazione Dolci e il suo amico e collaboratore Franco Alasia. Il trionfo dell’Eterno Paradosso Siciliano: la mafia che portava alla sbarra l’antimafia ottenendo, per di più, una sconcertante vittoria con la condanna dei due rappresentanti del Bene. Sul processo pesarono l’aria del tempo, ancora intrisa di «Onorata società>> e «Uomini d’onore»; l’assenza d’informazioni su Cosa Nostra, appena scalfita dalle misure di ordine pubblico assunte dopo la strage di Villabate (30 giugno 1963); la solitudine di Dolci e di Alasia nel denunciare complicità, malaffare, sottovalutazioni. A parte Michele Pantaleone e Pio La Torre, nessuno aveva voglia di credere che chi sedesse in Parlamento poteva esser stato «punciutu» o, addirittura, che sedesse in Parlamento proprio perché era stato «punciutu».
In quel clima di caccia a coloro che osavano aprire bocca, Mattarella e Volpe giocarono anche la carta di due eccellentissimi avvocati difensori, Giovanni Leone e Girolamo Bellavista, tra i massimi penalisti italiani, sorretti da potentati universitari e quasi sempre baciati dal successo nelle aule giudiziarie. Della loro veemente azione processuale scrisse lo stesso Dolci nel suo «Chi gioca solo», dalla pagina 329 in poi. Leone era anche il democristiano di rango, già presidente della Camera e presidente del Consiglio, nella cerchia ristrettissima dei papabili alla presidenza della Repubblica. Davanti a cotanta personalità nessuno ebbe voglia di ricordare che Leone aveva appena fatto assolvere il boss emergente della Cosa Nostra catanese, Francesco Ferrera. Spalleggiato dai cugini Nitto e Natale Santapaola e da un gruppo di picciotti, aveva ucciso a pistolettate un magnaccia in possesso solo di un coltello. Condannato in primo grado a 16 anni, in appello fu riconosciuta a Ferrera la legittima difesa, malgrado la sproporzione numerica e la sperequata dotazione di armi. Un trionfo processuale, per il quale Leone aveva incassato una parcella di 10 milioni (il prezzo di un quadrilocale nel centro di Milano). Fu tale la gratitudine della «famiglia» etnea, che nel ’71 l’elezione alla presidenza della Repubblica di Leone – chiamato oramai «zu Giovanni» – sarebbe stata salutata con tre giorni di festeggiamenti pubblici. D’altronde una decina di anni prima l’esimio statista aveva accettato di difendere, pure stavolta in appello, i quattro sperti e malandrini accusati di aver ucciso il sindacalista Salvatore Carnevale. Bastonati in assise, erano stati beneficiati nel processo di secondo grado da un’inattesa assoluzione per insufficienza di prove, poi confermata dalla Cassazione. E non era stato un caso se a sostenere la madre di Carnevale era giunto un altro futuro presidente della Repubblica, Sandro Pertini.
Anche Bellavista poteva vantare un degno curriculum, anch’esso riportato da Dolci nel suo «Chi gioca solo». Dopo la guerra aveva difeso Michele Navarra, il medico condotto alla guida della mafia di Corleone, il boss dei giovanissimi Leggio, Riina, Provenzano. Al sostegno di Navarra, Bellavista aveva dovuto la propria elezione alla Costituente e alla Camera nel 1948 con il partito liberale. Ma il non aver impedito una misura restrittiva del tribunale gli aveva alienato la protezione del dispettoso «capofamiglia»: nel ’53 era stato sonoramente bocciato assieme al Pli passato, nella circoscrizione di Palermo, da 66.000 voti a 25.000. Al povero Bellavista non era rimasto che diventare il legale di Leggio, l’assassino di Navarra, l’uomo che avrebbe guidato i corleonesi alla conquista di Palermo. Il tutto sullo sfondo della P2: il nome dell’avvocato vi sarebbe stato rinvenuto tre anni dopo la morte.
Questo, sinteticamente, il quadro nel quale maturò l’ingiusta condanna di Dolci e Alasia. I quali, alla luce di quanto oramai appurato fra indagini e confessioni dei collaboratori di giustizia, ci appaiono invece straordinari testimoni di verità in un’epoca di reticenze e omissioni in Sicilia e nell’intera nazione, perfettamente effigiate nell’incredibile lettera pastorale del cardinale di Palermo Ernesto Ruffini del 1964: «In questi ultimi tempi si direbbe che è stata organizzata una grave congiura per disonorare la Sicilia; e tre sono i fattori che vi hanno contribuito: la mafia, Il Gattopardo, Danilo Dolci … Alla mafia e al Gattopardo si aggiunge, per declassare la diletta isola, il pubblicista Danilo Dolci … Nel febbraio del 1952 venne a Trappeto, in provincia di Palermo, per iniziare quella campagna, apparentemente benefica, che doveva tanto corrompere in molti Paesi d’Europa il vero volto della Sicilia».
Ma se Ruffini ancora parlava della mafia come opera di alcuni delinquenti, o come di qualcosa da mettere assieme a Danilo Dolci, usata per diffamare la Sicilia, ben altre conoscenze ne avevano Calogero Volpe, con il suo schedario di 47 mila pazienti ai quali chiedere il voto, e Bernardo Mattarella, esponente politico di punta di un paese dove si aggiravano indisturbati i Buccellato, i Magaddino, Joe Bonanno e altri grandi mafiosi espatriati in America alla conquista del nuovo continente.
Caro Peppino, ti hanno fatto una statua a Ponsacco, scolpita da David Broggi, ti hanno dedicato alberi, strade e targhe in circa…
Antonio Gramsci scrisse che la Storia si ripete sempre e la seconda è una farsa.…
È passato poco più di un mese dal ritrovamento di Andrea Prospero, giovanissimo studente universitario di Lanciano,…
Sono passati oltre cinque mesi dall’archiviazione come “suicidio” della morte di Jois Pedone disposta dalla Gup del…
«A chi dà fastidio la memoria di Jois Pedone? Chi vuole cercare di intimidire la…
«Il caso di Vasto. Jois Pedone ucciso dalla luna?» è il titolo della puntata di…